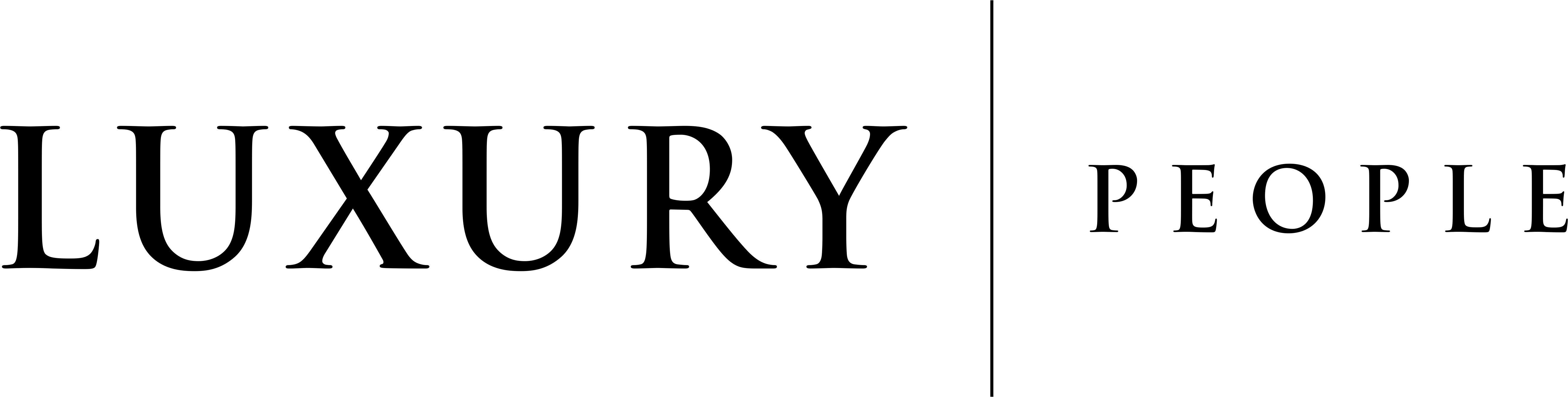Ci sono storie che non seguono una linea retta, ma assomigliano piuttosto a mappe emotive fatte di attraversamenti, soste e ritorni. Quella di Rajae Bezzaz è, prima ancora che una traiettoria professionale, un movimento continuo tra geografie e identità: dalla nascita in Libia alle radici magrebine, fino all’approdo in Italia. Un percorso che non produce fratture ma ampliamenti di sguardo ed è proprio da questa pluralità che nasce la sua capacità di entrare nelle pieghe più delicate della realtà sociale senza semplificarle, mantenendo uno stile che non alza la voce ma non arretra.
Volto noto di Striscia la Notizia, dove firma servizi su temi sociali complessi, affianca all’attività televisiva la conduzione radiofonica su R101. Nel libro L’araba felice (Cairo Editore) riflette sull’essere donna tra due mondi, trasformando l’identità in uno spazio di dialogo più che di conflitto. Il filo rosso che attraversa tutto il suo lavoro resta l’attenzione verso chi vive ai margini e verso storie che raramente trovano spazio nel discorso dominante: una narrazione che rifiuta scorciatoie emotive e sceglie, piuttosto, la complessità, il dubbio e il confronto.
Questa conversazione parte proprio da qui: dall’idea che capire l’altro non sia un esercizio di tolleranza, ma un atto di conoscenza e che raccontare la realtà significhi accettarne le contraddizioni continuando a cercare punti di incontro.
La sua storia attraversa più culture. In che modo le sue radici hanno influenzato il suo sguardo sulle disuguaglianze?
“Totalmente. Vengo da un Paese che ti dà tanto ma che, soprattutto, ti tiene attaccata alla vita vera, ai valori, alle difficoltà, alla concretezza dell’esistenza. È un contesto in cui i mondi si mischiano continuamente: chi sta bene e chi sta male convivono nello stesso spazio, e questa prossimità ti impedisce di distrarti, di vivere dentro una bolla. Questo ti permette di sviluppare una visione più ampia e, direi, quasi una predisposizione culturale alla sensibilità. Per cultura, per religione, per contesto sociale, impari a sentire anche ciò che apparentemente è distante da te. Le problematiche che magari non stai vivendo in prima persona smettono di essere “degli altri” e diventano qualcosa che ti riguarda, perché la prerogativa è non lasciare nessuno indietro.
È probabilmente la parte più bella della mia cultura marocchina, il Paese in cui sono cresciuta: un luogo estremamente ospitale che molti descrivono come l’Italia degli anni ’40 o ’50, un posto dove ci si guarda ancora in faccia, dove sai chi vive accanto a te, dove le difficoltà non si ignorano ma si condividono. Dare una mano non è un gesto straordinario, è quasi un riflesso naturale. Le mie origini mi hanno dato una struttura interiore molto solida, mi hanno aiutata a diventare la persona che sono oggi e anche a fare il lavoro che faccio. E quei valori, col tempo, li ho ritrovati anche in Italia. Non vedo una distanza così radicale tra le due culture come spesso si tende a raccontare.
Certo, Milano è una città frenetica: ti dà tantissimo ma ti toglie anche molto. Eppure percepisco una forte voglia di umanità, di verità, di essenziale. Forse, sotto la superficie, esiste un desiderio comune di tornare a una dimensione più autentica.
Chi cresce tra due mondi, però, conosce bene la condizione di mezzo: spesso vieni percepito come straniero ovunque, sia nel paese in cui vivi sia in quello da cui provieni. Diventi figlio di uno spazio intermedio che racchiude due culture, due religioni, due modi di guardare la vita. Quando questo incontro riesce diventa una ricchezza straordinaria, perché ti permette di prendere il meglio dell’Oriente e dell’Occidente. Quando invece fallisce, genera rabbia sociale, divisione interiore, la sensazione di non essere mai nel posto giusto al momento giusto.
Per questo penso che l’integrazione richieda uno sforzo reciproco. La frase che più detesto è: “Sei a casa nostra, devi fare come noi”. Ma cosa significa davvero casa nostra? Il mondo è di tutti. Siamo persone senza confini. L’inclusione può esistere solo quando c’è accettazione dell’altro nella sua diversità. È l’unica strada possibile per convivere pur sapendo che i contrasti esisteranno sempre”.
Essere cresciuta tra identità diverse le ha insegnato che il vero lusso è la libertà di essere sé stessi?
“Assolutamente sì. Il vero lusso, oggi, è continuare a essere sé stessi senza cedere al giudizio permanente che caratterizza la nostra società. Viviamo dentro una cultura della performance, amplificata dai social, dove sembra necessario aderire a un modello per essere accettati, quasi come se l’autenticità fosse diventata un rischio invece che una risorsa.
Nel mondo dello spettacolo questa pressione è ancora più evidente: sei sotto i riflettori tutti i giorni, anche quando non ci sei. Puoi essere frainteso, mal interpretato, ridotto a una percezione costruita da altri. Eppure riuscire a restare fedeli a ciò che si è rappresenta, per me, la forma più alta di crescita personale, oltre che un atto di libertà.
Essere autentici significa continuare a empatizzare, comprendere la realtà che ci circonda e non sentirsi mai arrivati. Quando pensi di esserlo e vedo molte persone cadere in questa illusione – in realtà stai rinunciando alla possibilità di evolvere. È un impoverimento umano prima ancora che sociale, perché finisci per isolarti, convinto di possedere l’unica verità.
Al contrario, la curiosità e la capacità di mettersi continuamente in discussione sono la base del crescere, come professionisti e come esseri umani. Il bello di questo lavoro è proprio potersi dire: “Fino a ieri pensavo questo, aspetta, forse non è così”. È lì che avviene la trasformazione.
Raccontare contesti in cui la libertà viene negata mi ha reso ancora più consapevole di quanto nulla si acquisisce per sempre. I diritti vanno difesi ogni giorno, altrimenti rischiano di diventare fragili. Questo lavoro mi tiene le antenne sempre alzate e mi ricorda quanto sia necessario continuare a lottare, per noi e per gli altri, perché spesso diamo tutto troppo per scontato”.

Da dove nasce questa forte idea di responsabilità?
“Nasce prima di tutto dalla mia storia familiare. I miei genitori hanno attraversato un continente per offrire a me, a mia sorella e a mio fratello una possibilità diversa. Hanno affrontato sacrifici enormi per farci ottenere documenti, istruzione, futuro, e tutto questo non può essere banalizzato né considerato scontato. Io, infatti, non do nulla per scontato. Quando cresci sapendo da dove sei partita, sviluppi quasi naturalmente un senso di gratitudine che diventa anche responsabilità. Vedere persone che continuano a lottare anche solo per i diritti più basilari mi porta ad apprezzare profondamente ciò che ho e mi mette nella condizione di fare meglio il mio lavoro. Lo sento come un dovere.
Tutti abbiamo bisogno, in certi momenti della vita, di qualcuno che abbia voce e forza, perché la forza non è eterna. Ci sono fasi in cui non ce l’hai e se puoi metterti in gioco per gli altri, allora devi farlo.
Credo che il nostro grado di umanità si misuri anche da questo: dalla capacità di non voltarsi dall’altra parte”.
Nel suo percorso ha spesso raccontato contesti in cui la libertà viene negata.
“Quando morì Mahsa Amini mi tagliai i capelli davanti all’ambasciata iraniana. Non perché fosse un gesto simbolico di tendenza, ma perché era il mio modo di esserci, di esprimere vicinanza a un popolo che in quel momento si sentiva abbandonato e chiedeva aiuto. L’avrei fatto anche senza telecamere, perché se scegli questo mestiere devi avere dentro la voglia reale di essere autentico, di dare voce, di spingerti oltre. Non può essere solo un lavoro — deve essere qualcosa che ti attraversa.
Dare voce significa anche attraversare la paura. Non vuol dire non provarla, ma decidere che non sarà la paura a determinare il tuo posizionamento. Essere presenti, per me, è una forma di responsabilità”.
Come si convive con il rischio?
“La paura non sparisce; ci si allena a governarla. Fin dall’inizio devo dire che non ne avevo molta, ma con il tempo impari a leggere i contesti. In questi anni ho visto crescere l’aggressività. Nemmeno le telecamere, oggi, funzionano più da deterrente. Dopo alcune aggressioni ho alzato la soglia di attenzione: non è paura, è lucidità. Significa proteggere la troupe, fiutare il pericolo, evitare conseguenze irreversibili. Rischiamo tanto, quindi impariamo a proteggerci a vicenda”.
Tra i temi che sente più urgenti c’è quello delle migrazioni
“Il Mediterraneo è diventato un confine di morte. Vite spezzate alla ricerca di un futuro che spesso non arriva. Raccontarlo è una responsabilità. Credo anche che il linguaggio abbia un ruolo fondamentale: affrontare temi durissimi con una chiave accessibile, come accade talvolta attraverso la satira, permette al messaggio di arrivare senza travolgere chi ascolta. Non si tratta di alleggerire il dolore, ma di renderlo comprensibile”.
Di recente ha affrontato anche la violenza sugli uomini.
“Non esiste una gerarchia del dolore. Parlare degli uomini vittime di violenza non significa togliere spazio alla battaglia contro i femminicidi, ma completare il quadro. Il nostro grado di civiltà si misura da quanto sappiamo prenderci cura di ciò che ci circonda, senza distinzioni di genere, passaporto o condizione. La violenza non deve avere categorie”.
Cinema, teatro, radio: cosa rappresentano per lei oggi?
“Sono tutti spazi di ricerca. Tornare sul set nel cortometraggio Sirens (Regia di Valter D’Errico ndr), interpretando una madre siriana che prova a proteggere la figlia mentre il mondo intorno crolla è stato emotivamente fortissimo.
Il teatro resta un luogo in cui un interprete impara davvero a mettersi in discussione.
E la radio mi obbliga a non ripetermi, a studiare, a informarmi. È uno dei motivi per cui amo questo lavoro: mi costringe ad abbattere la mia ignoranza”.
Progetti futuri?
“Mi sento in una fase di fame creativa, nel senso più vitale del termine. Non è solo ambizione: è curiosità. La curiosità di capire come cambiamo, da dove veniamo e come possiamo migliorare.
In questi giorni, per esempio, riprendiamo il laboratorio teatrale con Minima Theatralia. Torno in sala prove, riparto dalle lezioni, dal lavoro quotidiano, da tutto ciò che prepara uno spettacolo prima ancora che arrivi sul palco. Il 9 e 10 maggio al teatro Elfo Puccini a Milano, porteremo in scena “The Mary Shelley Picture Show – Making of, un remake dello spettacolo dello scorso anno: mi affascina sempre il dietro le quinte, capire come nasce una storia, attraversarne anche le difficoltà, gli inciampi, perfino le figuracce. È lì che accade la parte più vera del mestiere. Lavorare con Marta Marangoni, che considero una regista sublime e con una compagnia così viva e generosa è un privilegio. È una realtà che sprigiona arte e la condivide e io sono felice di farne parte.
Poi c’è la radio, che è un’altra mia linfa. Essere in onda ogni weekend alimenta la mia curiosità, attraverso ospiti e storie di vita vera, senza duplicare ciò che faccio in televisione. Voglio trovare sempre nuove chiavi di lettura, stare a passo con il tempo, ma soprattutto continuare a crescere.
Perché, in fondo, ciò che mi guida non è solo l’ambizione: è la curiosità. La curiosità di capire come cambiamo, da dove veniamo e come possiamo migliorare. Fare questo lavoro significa restare esposti al mondo e continuare a scegliere, ogni giorno, di non voltarsi dall’altra parte”.